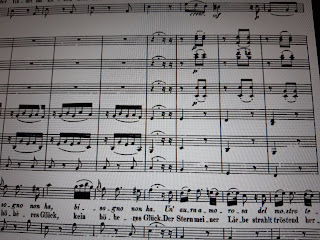Massimo Mila (1910-88) fu un grande musicologo e critico. Nato a Torino, fin dagli anni giovanili fu in contatto con personaggi importanti della cultura italiana, come Pavese, Ginzburg, Bobbio, Einaudi. Antifascista, patì il carcere. Fu anche traduttore dal tedesco di importanti opere letterarie, ad esempio da Goethe e da Hermann Hesse.
Tra i suoi lavori musicologici, nei quali sapeva unire la profondità del pensiero con la semplicità e la chiarezza di una esposizione sempre piacevole e affabile, vorrei ricordare oggi "
Lettura delle Nozze di Figaro", che Einaudi pubblicò nel 1979 nella celebre collana "Piccola Biblioteca", dedicata all'arte, all'architettura, al teatro, al cinema e alla musica.
Si tratta di un ciclo di lezioni tenute nell'anno accademico 1969-70 per gli studenti dell'Università di Torino. Il sottotitolo esprime la chiave interpretativa dell'autore: "
Mozart e la ricerca della felicità".
Il capolavoro mozartiano (tratto come ben noto dalla commedia di
Beaumarchais, adattata per l'opera in musica da
Lorenzo Da Ponte e rappresentata a Vienna nel 1786) è inquadrato nel contesto dell'evoluzione del teatro musicale del Settecento, di cui Mozart rappresenta l'espressione più alta.
Mila inquadra l'opera del genio di Salisburgo nel contesto del Settecento musicale, nel progressivo maturare ad una
concezione più moderna del teatro: si tratta del superamento dell'antica distinzione tra opera seria e opera buffa, nella quale il genere serio rappresentava una sorta di "opera-concerto", puro pretesto per la fioritura di meravigliose arie, e l'opera buffa era fondata su caratteri tipicizzati e stereotipati. La riforma di Gluck non aveva inteso perseguire la sostituzione del melodramma serio con altro ideale drammatico, ma solo un intento di ripulirlo dagli abusi, in particolare derivanti dal virtuosismo dei cantanti.
L'evoluzione dell'opera comica, verso la metà del secolo, era consistita nella maggiore osservazione della vita e dei caratteri psicologici. La staticità lasciava il posto al
dinamismo, in particolare nei
concertati, nei quali i vari personaggi si confrontano in dialogo serrato, interagiscono, si scontrano. Lo stesso Da Ponte, nelle sue "
Memorie", definì il finale d'atto "una specie di commediola o di picciol dramma da sé ... in questo principalmente deve brillare il genio del maestro di cappella, la forza de' cantanti, il più grande effetto del dramma ... e trovar vi si deve ogni genere di canto". Così fece Mozart negli straordinari Finali del II e del IV atto delle "Nozze". Il Finale II, ad esempio, "ingloba cinque scene ... e dà luogo a otto pezzi musicali distinti, ma susseguentisi senza interruzione, quando non addirittura concatenati e confluenti l'uno nell'altro" (Mila, p. 93).
L'opera comica aveva già conosciuto un'importante evoluzione con i lavori di Piccinni, Cimarosa, Paisiello, nell'accoglimento di nuovi contenuti (sentimentali, patetici, perfino tragici) e di conseguenza "un più denso e articolato pensiero musicale" (p. 13).
Nella riduzione librettistica di Da Ponte si nota una attenuazione della polemica politica di Beaumarchais, pur mantenendone l'assunto di fondo: il punto di vista che privilegia l'
evoluzione sociale e culturale del Terzo Stato di fronte alla decadenza dell'aristocrazia. Limitando il contenuto più manifestamente politico, secondo il Mila, Mozart "spoglia la trama di gran parte della sua 'attualità', per portarla in quell'
eterno sempre valido dove vivono i capolavori" (p. 20): la rappresentazione della "eterna ricchezza della vita dell'uomo, visto in una luce di superiore umorismo ironico", come già aveva evidenziato il grande studioso di Mozart,
Hermann Abert (1871-1927), nella sua monumentale monografia del 1919-24.
I personaggi ci appaiono in un perpetuo movimento, nel quale si spiegano sempre nuovi aspetti del loro carattere concreto, mobile, cangiante e imprevedibile, come la vita stessa. La forza motrice che genera questo movimento è l'amore: non a caso l'opera si conclude con la soluzione di quattro diversi accoppiamenti: Susanna con Figaro, la Contessa riconciliata con il Conte, Cherubino con Barbarina, Marcellina con Don Bartolo.
Già nella
Ouverture strumentale introduttiva, come ci ricorda il Mila citando Abert, "è stato messo in musica ... il naturale, sfrenato impulso vitale nel suo aspetto sereno, di gioia dell'esistenza. Tutto è movimento alla più alta potenza, in questo pezzo". Perciò il MIla sottolinea che l'Ouverture "prefiguri e compendi il significato stesso dell'opera" (pp. 28-29).
"
Le Nozze di Figaro" non rappresentano dunque più un esempio di
derbkomisch, cioè di comicità cruda, fine a se stessa, satirica, caricaturale, bensì un preannuncio del concetto romantico di
ironia, inteso come la rappresentazione della condizione umana (gioia e sofferenza), alla quale l'autore partecipa personalmente, coinvolgendo anche il pubblico e conducendolo verso la sfera alta della compassione, senza peraltro indulgere al sentimentalismo e alla retorica, ma quasi dissimulando. L'ironia mozartiana viene definita dal Mila col termine
litote, che in retorica consiste nell'attenuazione dell'enfasi, ottenuta mediante negazione del contrario (ad esempio:
"non sto molto bene", anziché "
sto male")
, al fine di eufemismo o anche di ironia. La litote mozartiana è per Mila il "pudore espressivo, la sensibilità acuta di quello che si può dire e di quello che deve soltanto essere accennato, suggerito; il riserbo, il rifiuto delle grandi parole, e della retorica che così facilmente vi si annida" (p. 182).
Tutto ciò conduce all'espressione di un
preciso messaggio morale, che consiste in una generale, grandiosa assoluzione, in un affettuoso abbraccio di
solidarietà umana, di reciproca comprensione, culminante nella richiesta di perdono rivolta dal Conte alla Contessa e all'accoglimento da parte di lei. Il Finale IV è visto dal Mila come "una svolta storica nella concezione poetica della notte, e fa da cerniera tra il superficiale edonismo settecentesco e la suggestiva concezione romantica". Con la risposta della Contessa alla richiesta di perdono del Conte "di colpo ci troviamo trasferiti in un clima religioso ... è un corale religioso, pieno di devozione e di fervore ... che proclama la suprema aspirazione dell'anima di Mozart ... che si appoggiava disperatamente al mito della felicità, all'età dell'oro, del paradiso terrestre che deve ritornare, cancellandosi attraverso la bontà e l'indulgenza le tracce del peccato originale" (p. 177).
La "religione" che Mozart intende esprimere, chiarisce il Mila, è dunque la
ricerca della felicità, secondo la
concezione giusnaturalistica teorizzata da Locke e poi dagli illuministi francesi. Il nostro critico collega acutamente questa teoria con il pensiero moderno di Sigmund Freud, espresso in particolare nel saggio "
II disagio della civiltà" ("
Das unbehagen in der Kultur", 1930). La ricerca del paradiso terrestre, secondo Freud, è contrastata dal nostro corpo, dal mondo esterno e dalle nostre relazioni interpersonali, per cui la felicità si riduce infine solo allo scampare all'infelicità, al sopportare la sofferenza, ad evitare il dolore. Tuttavia, sottolinea il Mila, Mozart sembra rifiutare questo atteggiamento di rassegnazione, così come la sua possibile alternativa nello sfogo dell'aggressività violenta, evidenziando piuttosto un ideale filantropico, bene espresso dalla "
gentilezza curvilinea" della sua musica (p. 181). Il punto di arrivo di questa ricerca sarà il "
Flauto magico".
Il protagonista
Figaro è la rappresentazione perfetta di questa poetica teatrale e musicale: il genio di Mozart "non ha accettato di gettare subito Figaro in pieno stile buffonesco". Il fondo pessimistico del suo animo viene a galla, nonostante la buffoneria; è "l'umorismo di chi fa lo spiritoso facendo strazio delle proprie sventure" (pp. 152-153).
Susanna, "servetta sbarazzina ... popolana maliziosa, ma onesta" sviluppa nel quarto atto "la sua prerogativa di ragazza sana e naturale, che nell'imminenza delle nozze affretta col pensiero le gioie che l'attendono" (p. 158).
"Autentico antagonista" della vicenda, il
Conte "per i suoi capricci amorosi è disposto a lottare, a battersi, a commettere ingiustizie e soprusi ... non è un frivolo, non è solo un cavaliere galante in caccia d'avventure ... non è da stupirsi che tale personaggio si sviluppi fin quasi al tragico ... non è mai personaggio di opera buffa" (p. 58). "Due fattori musicali traducono la tempesta di sentimenti che si agita nell'animo del Conte: il frequente mutamento dei tempi ... e l'irrequieta instabilità tonale ... quasi simbolo del suo animo diviso" (p. 123).
L'essenza del personaggio della
Contessa è, per il Mila, "l'equilibrio nella tenerezza e nella malinconia, l'unitarietà" (p. 68); il suo canto sembra venire "da quel paradiso perduto che è al fondo della poetica mozartiana" (p. 69). "Come annota l'Abert, tanti sentimenti ondeggiano nell'anima della Contessa" e il Mila li elenca, citando l'autorevole collega: "nostalgia, fiducia, presentimento angoscioso, tenera speranza" (p. 70). "Non c'è nella Contessa né violenza né durezza, né rivolta contro la sorte" (p. 71).

Lo straordinario personaggio di
Cherubino è "l'adolescente che esce di fanciullezza, e che scopre vagamente, a tentoni, in maniera ancora assolutamente indeterminata, la forza motrice dell'amore ... innamorato di tutte le donne, e più precisamente innamorato dell'amore" (p. 46). Citando Kierkegaard, Mila ci avverte che "in Cherubino ... la sensualità si sveglia ... non come piacere e gioia, bensì come profonda melanconia". E con Abert: "il risveglio dell'amore ancora seminconscio, in un cuore d'adolescente, con tutta la sua emozione febbrile, la sua dolce tortura e la sua intera mancanza di direzione" (p. 47). "In fondo Cherubino sta male, e i grandi ridono di lui, perché sanno benissimo che cos'ha ... è come una firma mozartiana ... autoritratto involontario di chi aveva saputo conservare inalterato il dono della fanciullezza - cioè la capacità e la voglia di giocare - malgrado le più severe prove della vita" (pp. 48-49).

Di fronte a questi cinque personaggi straordinari, rappresentati nella complessità di sfaccettature delle persone reali, i comprimari,
Bartolo,
Basilio,
Marcellina,
Antonio,
Don Curzio, sono i portatori della staticità caricaturale che era tipica dell'opera buffa tradizionale.

Mentre in
Barbarina il Mila riconosce la "solitudine infantile nel mondo dei grandi", collegandola ad esperienze molto più recenti di teatro musicale, citando un esempio dall'opera di Debussy.
Il grande musicologo ci conduce passo, scena dopo scena, nella "lettura" avvincente di questo capolavoro mozartiano, trionfo della bellezza, nel quale ognuno e ognuna di noi ancora oggi può rispecchiarsi e trovare qualcosa di se stesso.